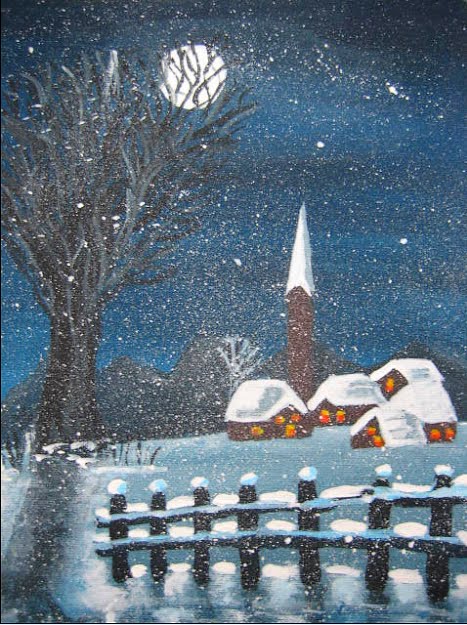Ma non c’è solo la stalla. I bovini mangiano. Hanno bisogno di foraggio. E dunque lo stalliere si trasforma, nella stagione estiva, in procacciatore di vegetali per il sostentamento degli erbivori. Una volta i piccoli allevatori (sostanzialmente ogni capo famiglia), quelli con due, tre, cinque vacche nella stalla, controllavano il grado di maturazione dell’erba, prima della falciatura. Sapevano che la sua buona qualità era fondamentale per garantire agli animali un adeguato alimento per l’inverno. I prati, tutti, erano dei campi in fiore: l’azzurro delle salvia e il rosa carico della lupinella s’alternavano al giallo oro della ginestrina, a quello meno intenso della vulneraria e al bianco/rosa tenue dell’achillea, al rosso/viola della centaurea. L’erba profumava. E quando ci si avvicinava alla sfioritura, solo allora iniziavano le operazioni della segagione. Perché il fiorime che poi decantava sotto l’assa dal fen era apprezzato dai bovini. Con esso si preparavano succulente mestüre, che – immagino – rallegrassero le vacche durante la lunga stagione invernale nella semioscurità delle stalle di una volta…
Da tempo però le cose sono cambiate. Oggi lo sfalcio è un pretesto. Diciamo, più o meno, una furberia ai danni delle finanze pubbliche. Per introitare contributi. Per poter edificare in zone altrimenti precluse e magari farsi la villa o in alternativa l’ agritur… I prati non profumano più di fiori colorati. Servono soltanto per disfarsi dei liquami della stalla. Della pissigna. All’inizio della primavera le bótti cariche di escrementi liquidi fanno la spola tra le vasche di raccolta e i prati dove vengono svuotate. Idem dopo ogni sfalcio allorquando il tempo minaccia pioggia. L’ammoniaca, concentrata nella pissigna in quantità spaventose, brucia le sementi dei fiori, i prati si trasformano in orribili selve di velenose ceviti (conium maculatum). Le quali, appena mature, rinsecchiscono velocemente colorando le praterie di un triste uniforme giallo-marroncino. Il fiorime non c’è più. Le cornute si accontentino delle farine e dei mangimi! E’ la modernità, bellezza. Gli allevatori di montagna, sui quali per opportunità politica i nostri amministratori spesso fanno facile apologia, costretti a barcamenarsi col mercato del latte (e del primario in generale) globalizzato e dai margini economici ristrettissimi, operano sostanzialmente come quelli di pianura, ma con la non trascurabile differenza che lì la resa quantitativa è enormemente maggiore. E infatti, da noi, senza i copiosissimi contributi che l’ente pubblico provinciale eroga a queste attività, dal punto di vista economico l’intrapresa sarebbe assolutamente deficitaria. Facendo un semplice conto della serva si può osservare sbalorditi che a fronte di un capitale animale di poche decine di migliaia di euro, queste nostre imprese zootecniche dispongono di macchine, macchinari e attrezzatura per centinaia di migliaia di euro. Insomma, pur riconoscendo che questo lavoro in ogni caso è duro, durissimo, a prescindere e che qualcuno lo farà di certo con passione, considerando la scarsa resa economica e il fatto che da un po’ di anni si riscontri un proliferare un po’ ovunque di “stalloni” con annessi villa e barbecue, qualche dubbio sulle vere finalità di questa attività è legittimo… Comunque, dubbi o non dubbi, passione o non passione, una cosa è certa: la forma mentale degli appartenenti alla categoria dei bacani è omogenea.
Quel giorno, quando arrivai nel campo, Martino e i suoi fratelli stavano cercando di sechentàr proprio quella sottospecie di foraggio brunastro in località Roncosogno. Erano stati giorni di piogge e le ceviti, ancorché ŝà šecche ‘n pè erano fradice d’acqua. Anche se l’instabilità del tempo avrebbe dovuto sconsigliare qualsiasi proposito de begàr co i atrezi, la stagione inoltrata li aveva indotti all’azzardo. Falciatrici, trattori, ranghinatori, rastrelli e uomini erano sparsi qua e là nell’ampia piana che si estende a est dell’abitato della piccola frazione teserana, verso Panchià, sulla sinistra orografica dell’Avisio. Proprio lì, dove da alcuni anni, coltivo un piccolo campo di circa mezzo staio, a patate e fagioli. Memore del disastro che la peronospora aveva provocato l’anno precedente, avevo intenzione di fare un trattamento preventivo col verderame per un possibile attacco della terribile fungina (ma anch’io azzardavo: se avesse piovuto di lì a poco il trattamento sarebbe stato del tutto vano). Dopo, se mi fosse avanzato del tempo, avrei voluto sfodegàr te i patatari per vedere come che le mossava. Dunque, entrando dalla stretta strada di accesso interpoderale, avevo percorso una quarantina di metri sul prato sfalciato e già sgombro d’erba col mio “ape” per poter portare il necessario, una pompa irroratrice, una tanica d’acqua e un po’ di attrezzi, in prossimità del šedime del medesimo campo.
Scaricato il tutto avevo iniziato il lavoro. Improvvisamente, passati pochi minuti, il caratteristico rumore di azionamento della pompa a mano venne soverchiato da uno stentoreo Dio pooorco!. Riconobbi la voce (non feci fatica) e mi girai quasi interdetto. Vidi la faccia tra il beffardo e l’ostile di Martino che, evidentemente, covava da chissà quanto la voglia di cantarmele, e rimasi ad ascoltarlo senza parlare. Ma no ŝon miga d’accordo cossita! Te l’aveva ben dito l’an passà che no te pös vegnir into con l’ “ape”! Porco dio! Te pös vegnir into sol a meterle e a cavarle!... Quante olte tel cogne dir? Dio porco! A quel punto s’interruppe. Restai ancora un momento in attesa e poi visto che non proseguiva capii che la sua lectio magistralis era già terminata. Allora tentai di replicare e almeno un po’ di ragionare: Probabilmente, ‘n ponta de diritto, ti t’as reson e mi ae torto, però se no ne perdon massa te le monae, che te cambielo? Mi šon šul mio, ‘l resto l’è ŝa šiegà. Le tre olte de numero che šon vegnü into sin qua con l’ “ape”, par no te dar despiašer t’ae addirittüra šiegà ‘l viacio e portà l’erba sin föra la stala. Me l’ae descargàda, ghe l’ae data into a le vacche,... che voe pü che merda no ghe dasé... E po’, vardete ‘ntorno…, avé qua na mesa de mezzi te tutta la piana. Še qua con trattori con rode che ghe völ la scala a montar šü, machine da šiegar, ranghinatori… e te stas qua a romper i cojoni parché šon vegnù into par la terza olta ten tré meṧi con l’ “ape” 40 metri tel šiegà par me portar sin qua sta roba che peṧa… Ma l’altro – come prevedibile – non sentiva ragione (il diritto d’altronde era sempre stato il suo punto forte): ma no, no, dio porco, no te pös, e basta!... A quel punto, capendo che continuare sarebbe stato tempo sprecato, gli tirai giù, a mia volta, un po’ di sacramenti, tanto perché la finisse. L’incanto della mattinata agreste era ormai svanito. Dopo un po’ lasciai il lavoro e me ne andai, discretamente alterato.
Il giorno appresso, sperando di aver miglior fortuna e non imbattermi nuovamente nell’irragionevolezza di quell’uomo, ritentai la sorte e scesi di nuovo al campo. Per non provocare eventuali altri dispiaceri fermai l’ “ape” föra i Stefenati pur sapendo che avrei dovuto fare più di un viaggio per portare a mano, dal motocarro al campo, quel che serviva per proseguire il lavoro interrotto. Mi accorsi però immediatamente, ancor prima di metter piede nei prati antistanti, che un’inaspettata rappresaglia per le mie incaute parole del giorno innanzi era stata compiuta. L’olezzante profumo di lavanda francese che si poteva percepire a distanza e il bel marrone intenso della piana non lasciava alcun dubbio in merito. Guardando sconsolato quel lago di pissigna, ripensai alle alte parole di Martino e a quanto era stata opportuna e soprattutto logica la sua magistrale lezione di diritto… Contemporaneamente però realizzai che lo studio americano sugli effetti dell’ammoniaca doveva essere indubbiamente esatto.
A.D. – tratto da “Il paese dei Sapienti”