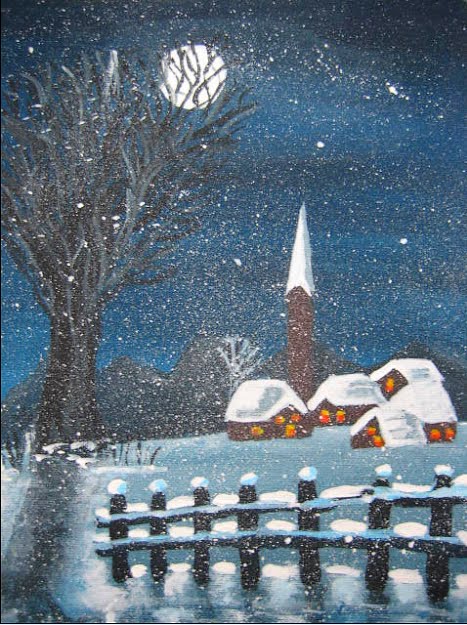Giugno la falce in pugno, luglio l’avena e il grano, agosto…Bartolomeo ti riconosco. Finalmente ci risiamo …e la festa continua. Riecco il grande tazebao, sotto gli orti del Comune, che annuncia puntuale la festa delle feste: San Bartolomeo. Ah, quanto l’avevamo attesa! Non vedevamo l’ora. San Liseo al confronto… Ma attenzione, lo puntualizziamo per i meno avveduti: questa sagra è una purissima invenzione propagandistica tirata fuori, poco meno di venti anni or sono, dal cilindro dei maghi della promozione turistica locale, da sempre annidati nel privatissimo consiglio d’amministrazione della ITAP s.p.a. e in quello meno privato (ma non di molto) del Comune. Non a caso la “strapaesana de la birra, de la polenta e de le lüganeghe” si celebra proprio ai 1750 di Pampeago. E quel santo, Bartolomeo, dopo una sbrigativa ricerca, lo si scomodò dal suo perfetto anonimato soltanto perché dotato di una semplice ma indispensabile caratteristica: il suo onomastico coincideva esattamente con l’apogeo della stagione estiva in quota e con un periodo statisticamente clemente del tempo. Ma c’è di più, San Bartolomeo è in verità solo un prestanome. Il vero festeggiato della tre giorni pampeaghiana è quel san Piero da Tesero non ancora santo nei Cieli ma già santissimo in Terra. Particolarmente proprio in quella terra di confine tra la pala di Santa e il Cornon in cui “ab immemorabili” è oggetto di culto e di venerazione da parte dei pellegrini che ivi copiosamente transitano. Quel san Piero da T di cui il più celebre miracolo che si ricordi e che si ripete ogni anno, quasi ogni giorno, da novembre ad aprile è quello della trasformazione dell’acqua in neve (anche quando di nuvole non ce n’è e splende il sole) e successivamente, soprattutto!!, della neve in soldi. Ma questa è un’altra storia di cui riparleremo in altra occasione.
Torniamo dunque alla festa. La sagra di San Bartolomeo è la celebrazione più importante della comunità o per meglio dire della famiglia teserana, del tutto si tiene e tutto s’accosta, del sacro al profano, del pubblico al privato, “de i bali a le bale” (termine quest’ultimo che qui a Tieser, vuol dire al contempo bugie e sbornie, entrambe le accezioni ben confacendosi quindi all’occasione). Insomma la solenne apologia della perfetta teseranità. È questa l’occasione attesa dai maggiorenti locali per ricomporre il gregge, ricucire gli strappi con la dissidenza, architettare nuove furberie, richiamare parti della società recalcitranti, promettere favori, pagare biceri (il giusto, non si esageri!) al Toni, al Bepo e al Franzele, eccetera. Pampeago per tre giorni, intorno al 24 di agosto (dal venerdì sera più prossimo a quella data sino alla domenica sera successiva) diventa il catino culturale del paese. Fiumi di birra passano dai barili pressurizzati di alluminio alle pance dei giovani virgulti locali e successivamente fiumi di altrettanta bevanda spumosa si spandono (dopo breve ma opportuna stagionatura negli intestini degli stessi virgulti) sui prati dell’Alpe. Migliaia di autoveicoli fanno la spola tra il paese e la stazione turistica, s’inerpicano dai 1000 di T ai 1750 di P disegnando lungo il tragitto un festoso e olezzante serpente d’auto che trasporta, sul calar delle tenebre, la migliore gioventù del luogo alla ricerca del tempo perduto e di inebrianti scacciapensieri. Ed è giusto e sacrosanto che così sia. Perché quel san Piero da T, pardon, quel San Bartolomeo, che qui a tutto provvede, proprio questo pretende. E non è un caso, se, con acconcia deferenza, volonterosi e indulgenti carabinieri appostati alle “Tabelle” fermano solo di tanto in tanto chi rientra al paesello dopo la lieta nottata. Capita invero a volte, pur con quel gran santo che sorveglia, che gli alcol test comprovino impietosamente quanto si sia alzato il gomito e che quindi la cultura da poco immagazzinata all’Alpe si svapori in poco più di un respiro dentro a un palloncino. Vabbè… pazienza, ne valeva comunque la pena! Il sabato bis. Di nuovo gioiosi caroselli d’auto. Il tendone trabocca di giovani teserani; gli ingredienti ancora quelli: aria buona, musica di qualità, disquisizioni sul sacro, silenziose meditazioni e per i più meritevoli, dopo l’ascesi, figa!! E arriva finalmente la domenica: il clou. Sul proscenio naturale della sagra, con il mirabile sfondo del Latemàr, entrano in commedia anche gli anziani. La festa si fa più seria. Santa messa, (mai che la si faccia franca, cazzo!), coro, banda, comunioni, benedizioni, l’immancabile polenta, di nuovo biceri, “bali e bale”: tutto l’armamentario evocativo ben dispiegato, non manca nulla; e poi ancora fiumi di birra dentro, fiumi di piscio fuori. L’apoteosi è vicina, il meriggio sta velocemente passando. Dal cielo che sovrasta l’ameno e virtuoso ritrovo, per intercessione del Nostro Santissimo, il Sacro Spirito del paese, soddisfatto della prova data ancora una volta da quella sua valorosissima gente, ridiscende, sull’intera collettività finalmente rinsavita. Per un anno ancora il paese sarà di nuovo un solo ovile sotto un solo pastore.
Il sole sta tramontando. Il tendone è una camera a gas d’aliti d’aglio e di alcol, la percezione del tutto si fa più confusa. Di tanto in tanto pare si avvicini un temporale; ma no, no… non eran tuoni, erano rutti! Mesta s’avvicina l’ora dell’addio. Si rigira la chiavetta, i motori dei giovani virgulti ritornano a esalare inebrianti aromi di gasolio combusto che si miscelano con l’odore delle ultime lűganeghe rostìe. La folla, stanca ma felice risale sugli obbedienti e lucidi fuoristrada che in breve, rombanti, ridisegnando un lungo monocromatico serpente di lamiere argentate, ripercorrono la strada verso valle. Sull’Alpe, lentamente, ritorna la quiete. Le vacche ancora al pascolo ringraziano il Santo Patrono.
Torniamo dunque alla festa. La sagra di San Bartolomeo è la celebrazione più importante della comunità o per meglio dire della famiglia teserana, del tutto si tiene e tutto s’accosta, del sacro al profano, del pubblico al privato, “de i bali a le bale” (termine quest’ultimo che qui a Tieser, vuol dire al contempo bugie e sbornie, entrambe le accezioni ben confacendosi quindi all’occasione). Insomma la solenne apologia della perfetta teseranità. È questa l’occasione attesa dai maggiorenti locali per ricomporre il gregge, ricucire gli strappi con la dissidenza, architettare nuove furberie, richiamare parti della società recalcitranti, promettere favori, pagare biceri (il giusto, non si esageri!) al Toni, al Bepo e al Franzele, eccetera. Pampeago per tre giorni, intorno al 24 di agosto (dal venerdì sera più prossimo a quella data sino alla domenica sera successiva) diventa il catino culturale del paese. Fiumi di birra passano dai barili pressurizzati di alluminio alle pance dei giovani virgulti locali e successivamente fiumi di altrettanta bevanda spumosa si spandono (dopo breve ma opportuna stagionatura negli intestini degli stessi virgulti) sui prati dell’Alpe. Migliaia di autoveicoli fanno la spola tra il paese e la stazione turistica, s’inerpicano dai 1000 di T ai 1750 di P disegnando lungo il tragitto un festoso e olezzante serpente d’auto che trasporta, sul calar delle tenebre, la migliore gioventù del luogo alla ricerca del tempo perduto e di inebrianti scacciapensieri. Ed è giusto e sacrosanto che così sia. Perché quel san Piero da T, pardon, quel San Bartolomeo, che qui a tutto provvede, proprio questo pretende. E non è un caso, se, con acconcia deferenza, volonterosi e indulgenti carabinieri appostati alle “Tabelle” fermano solo di tanto in tanto chi rientra al paesello dopo la lieta nottata. Capita invero a volte, pur con quel gran santo che sorveglia, che gli alcol test comprovino impietosamente quanto si sia alzato il gomito e che quindi la cultura da poco immagazzinata all’Alpe si svapori in poco più di un respiro dentro a un palloncino. Vabbè… pazienza, ne valeva comunque la pena! Il sabato bis. Di nuovo gioiosi caroselli d’auto. Il tendone trabocca di giovani teserani; gli ingredienti ancora quelli: aria buona, musica di qualità, disquisizioni sul sacro, silenziose meditazioni e per i più meritevoli, dopo l’ascesi, figa!! E arriva finalmente la domenica: il clou. Sul proscenio naturale della sagra, con il mirabile sfondo del Latemàr, entrano in commedia anche gli anziani. La festa si fa più seria. Santa messa, (mai che la si faccia franca, cazzo!), coro, banda, comunioni, benedizioni, l’immancabile polenta, di nuovo biceri, “bali e bale”: tutto l’armamentario evocativo ben dispiegato, non manca nulla; e poi ancora fiumi di birra dentro, fiumi di piscio fuori. L’apoteosi è vicina, il meriggio sta velocemente passando. Dal cielo che sovrasta l’ameno e virtuoso ritrovo, per intercessione del Nostro Santissimo, il Sacro Spirito del paese, soddisfatto della prova data ancora una volta da quella sua valorosissima gente, ridiscende, sull’intera collettività finalmente rinsavita. Per un anno ancora il paese sarà di nuovo un solo ovile sotto un solo pastore.
Il sole sta tramontando. Il tendone è una camera a gas d’aliti d’aglio e di alcol, la percezione del tutto si fa più confusa. Di tanto in tanto pare si avvicini un temporale; ma no, no… non eran tuoni, erano rutti! Mesta s’avvicina l’ora dell’addio. Si rigira la chiavetta, i motori dei giovani virgulti ritornano a esalare inebrianti aromi di gasolio combusto che si miscelano con l’odore delle ultime lűganeghe rostìe. La folla, stanca ma felice risale sugli obbedienti e lucidi fuoristrada che in breve, rombanti, ridisegnando un lungo monocromatico serpente di lamiere argentate, ripercorrono la strada verso valle. Sull’Alpe, lentamente, ritorna la quiete. Le vacche ancora al pascolo ringraziano il Santo Patrono.
Tratto da "IL PAESE DEI SAPIENTI" di Ario Dannati