02/01/10
31/12/09
SÌ, SONO FRUSTRATO (MA SONO IN OTTIMA COMPAGNIA)

TESERO, I RETI E IL CENÈSTRO DI SAN SILVESTRO

Che fare? Che suggerire? Volevamo qualcosa che fosse al contempo vicino alla nostra gente e lontano nella storia. Pensa che ti ripensa… storia, nostra gente… nostra sente… nošša ŝente… Eureka! Ma certo che sì: Tarcio Rasu! Chi altri? Ecco l’uomo che di sicuro avrebbe trovato quel che cercavamo. E difatti…
Innanzitutto però, per soddisfare una curiosità che ci stuzzicava da un po’, volevamo capire bene l’origine storica di questa strana usanza della gozzoviglia di fine anno. Con la sua solita grande disponibilità, in modo semplice ed esaustivo, il famoso tuttologo teserano (ma di origini rom) grande esperto di usanze e tradizioni, ci ha spiegato che tale consuetudine origina addirittura dalla preistoria: all’epoca dei Reti, che proprio a Tesero (Tesero, sempre Tesero, è incredibile ma tutto sembra sia partito da questo paese!) nella località di Sottopedonda si insediarono nel V secolo avanti Cristo… Spiega Rasu: “Quelle nostre antenate popolazioni, in particolari ricorrenze del ciclo temporale, usavano offrire simbolicamente alle loro divinità i frutti della terra. Ma – precisa – la tradizione della venerazione di divinità antropomorfe è addirittura precedente (VI secolo a.C.). Possiamo supporre che presso i Reti esistessero dei santuari dedicati alla natura. E, a quanto ne so, a Sottopedonda venne praticato soprattutto il culto della fertilità: veniva offerto del grano, in boccali e in tazze, che avevano anche iscrizioni votive e riportavano il nome dell’offerente, esprimendo un nuovo tipo di rapporto con il divino, cioè il desiderio di essere in contatto con la divinità in modo personale e permanente. Le offerte erano bruciate, alternativamente, su cumuli di pietre con pozzo centrale, su piattaforme o su piani argillosi. In quel lontano tempo, il calendario retico, molto simile a quello etrusco, non prevedeva naturalmente la corrispondenza tra i giorni dell’anno e il genetliaco delle divinità, caratteristica introdotta oltre duemila anni dopo da papa Gregorio XIII con la famosa bolla «Inter Gravissimas» del 24 febbraio 1582. Il conta-giorni retico legava soltanto particolari date alle più importanti divinità di quel popolo. L’ultimo giorno del calendario retico era dedicato non a un’unica divinità, bensì a tre: il dio Silvino, il dio Silvone e il dio Silvestro (quest’ultimo poi recuperato nella tradizione cristiana). In quel giorno a quei tre dei, protettori della terra e dei suoi frutti, si dedicavano riti propiziatori che culminavano con libazioni notturne collettive all’aperto, dei veri sabba ante litteram con fuochi, canti, ubriacature ed orge. Soltanto un secolo dopo i Reti aggiunsero alle libazioni l’usanza del pasto serale. E qui – chiarisce Rasu – c’è un errore clamoroso nell’abbinamento onomastico della cena di fine anno. Infatti si crede che al dio Silvestro (poi come detto trasformato dalla tradizione cristiana in san Silvestro n.d.r.) sia abbinato il famoso cenone. In verità a quel dio si legava il cenèstro. E, correttamente, oggi si dovrebbe dire il cenèstro di San Silvestro…”
E gli altri due che fine han fatto? Chiediamo a Tarcio Rasu. “Beh, gli altri due, Silvino e Silvone, hanno avuto destini diversi. Silvino è stato ripescato e trasformato in san Silvino e si festeggia il 12 settembre mentre Silvone con quel suo grossolano accrescitivo è stato definitivamente accantonato. Nella tradizione popolare teserana il 31 dicembre però tutte e tre le divinità retiche vengono ancora festeggiate, con tre distinte sfumature che corrispondono esattamente ai suffissi dei rispettivi nomi. Perciò, predisponendo un menù più consono ai tempi grami di questo 2009 che sta per chiudersi, si parlerà del cenino di san Silvino, diversamente, infischiandosene e grandassando, come faranno comunque alcuni, si parlerà del cenone di san Silvone. Il cenèstro, stando nel mezzo, corrisponde nient’altro che a una semplice cena.” Dopo questo dotto excursus (prei)storico, sbalorditi per l’impressionante sapienza del nostro esimio compaesano, salutiamo Tarcio Rasu e proseguiamo il nostro viaggio nella tradizione locale dell’ultimo dell’anno.
Dunque, arrivando all’attualità, in pochi forse sanno (neppure noi lo sapevamo, e anche di questo dobbiamo ringraziare Rasu) che, a seguito dei ritrovamenti archeologici di Sottopedonda del 23 settembre 1987 il Comune, accortamente, con delibera giuntale del 20 aprile 1988, istituì un gabinetto parascientifico per "lo studio e la trasposizione mediante travaso della tradizione retico-sottopedondica in quella teserana" (così testualmente è scritto nella delibera). Con voto unanime la Giunta comunale decise di affidarsi a un triumvirato di saggi, con mandato a vita, composto per l’appunto da Tarcio Rasu per la consulenza storica, da Mario Fanìn per la consulenza agro-pasto-alimentare e dal compianto Matteo Baèsta per la delicata e fondamentale consulenza spirituale. Dopo un lungo e approfondito studio dei reperti storici rinvenuti, durato più di sei anni, questo comitato di saggi elaborò e predispose il cosiddetto Protocollo Ufficiale R/Sottopedonda. Il documento, custodito presso l’ufficio Storia e Costume del municipio, tra l’altro definisce esattamente le tre cene di derivazione retica che possono venire preparate a Tesero la sera del 31 dicembre. Grazie al protocollo anzidetto, Tesero si è garantito una sorta di D.O.P. (denominazione di origine protetta) che tutela il consumatore forestiero da ogni eventuale imitazione truffaldina portando ulteriore rinomanza al paese. La procedenza non è affatto complicata: scelta la divinità, ovvero il santo cui dedicare il pasto serale dell’ultimo dell’anno e la corrispettiva ampiezza del menù, non rimane che mettersi ai fornelli. Per il cenino gli ingredienti sono basilari: farina de méo e acqua. Lo chef ci ha spiegato che con queste due sostanze, per quanta buona volontà ci si possa mettere, il risultato è uno e soltanto uno, panada essenziale. Sempreché sia disponibile del fuoco per trasformare la farina in pane dessavì e il pane dessavì poi in panada dessavida, altrimenti si regredisce ancora oltre e si potrà ottenere semplicemente farina de méo smöada in acqua fredda. Non è un granché, però, stando almeno a quanto ci dice il noto chef locale Toni Nisi, la farina smöada dieteticamente è indicata per gli smilzi e per gli obesi, indifferentemente… Per il cenèstro vengono aggiunti altri ingredienti che aumentano il tasso proteico del basto. Oltre a quelli base, già inclusi nel cenino, in questa variante si aggiungono sale, brama di capra e ravi. E qui il cuoco può davvero liberare la fantasia. Con farina de méo, sale, acqua, brama di capra e ravi le combinazioni gustative si ampliano esponenzialmente. Elenchiamo i principali abbinamenti studiati e inseriti in una postilla del Protocollo (Ricettario retico) dal consulente Fanìn: peta de ravi con brama crüa, peta de ravi con brama cotta, strudel salà de ravi con brama rostìa, brama crüa con brama rostìa, pan e ravi cotti, pan e ravi crüi, farina de meo e acqua, farina de meo e pan, pan e pan. Infine il Cenone, per la verità non molto in voga nel nostro paese (la semplicità da sempre è la nostra caratteristica), comprende tra gli ingredienti, come ci ricorda sempre il consulente agro-pasto-alimentare, la poìna. È l’unico aggiuntivo previsto nel Protocollo. Poìna di capra, non vaccina - i Reti allevavano soltanto capre -. La poìna, quantunque un adagio locale dica che “pü che še n’ magna manco še camina”, fa bene ed è buona anche da sola, ma si può combinare con le precedenti pietanze del cenino e del cenestro. Con essa gli accostamenti sono infiniti ma per ragioni di spazio qui evitiamo di elencarli. Comunque, in caso di urgenti necessità, dato che in questi giorni gli uffici comunali sono chiusi, copia completa del Ricettario retico è disponibile anche presso l’abitazione del saggio agro-pasto-alimentare Mario Fanìn, in via Fia 9, al quale potete rivolgervi senz’altro con fiducia.
Insomma, cari lettori, certi di aver colmato una piccola ma importante lacuna storica e di avervi dato una inaspettata dritta per concludere come si deve l’ultimo giorno del decimo anno del primo decennio del terzo millennio, non ci resta che invitarvi a sbizzarrirvi con tutto questo retico ben di dio. Abbiate fiducia e non abbiate fretta. Cucinate con cura. Stupirete amici e parenti facendo un figurone. Inoltre, cosa non secondaria, il basto vi costerà poco, non farete indigestione (forse) e in ogni modo, in questi tempi di memoria corta, ve lo ricorderete per un gran pezzo. Almànco sin a la marèna del primo de l’an.
Evviva!
Ario Dannati
29/12/09
COCAINA: DA FREUD ALLA COCA COLA. TUTTE LE PISTE DI UNA STORIA OCCIDENTALE

Nel 2011 i consumatori di cocaina saranno circa 700mila, il 5% in più rispetto al numero di consumatori del 2008». Scriveva il Corriere della Sera quest'estate. E questo è solo uno dei continui articoli, inchieste, scoperte che i mezzi di informazione pubblicano quasi quotidianamente sulla cocaina. Come se il grande consumo della sostanza fosse stato scoperto soltanto adesso. Invece, quella della cocaina è una storia che non inizia neanche in questo millennio bensì si perde nella notte dai tempi. Recentemente le nuove tecnologie hanno potuto trovare traccia nei capelli di mummie cilene del 2000 a.C. della presenza di benzoilecgonina, un metabolita della cocaina. Al nostro secolo si deve tuttavia l'uso degli effetti per la ricreazione, il proibizionismo, ma soprattutto il grande volume d'affari. Nel 1884 il dottor Sigmund Freud pubblica un volumetto a lui tanto caro Über Coca. Il padre della psicanalisi racconta con molto entusiasmo, la scoperta di questa sostanza sperimentata su sé stesso per curare la depressione. In una lettera del 21 aprile del 1884 così racconterà alla fidanzata: «Ho letto della cocaina (….) Me ne sto procurando un po' per me e poi vorrei provarla per curare le malattie cardiache e gli esaurimenti nervosi…». Purtroppo però la natura è crudelmente avara nel dispensare il piacere. Più l'esperienza è eccitante, più il cervello soffre quando si rende conto che è già finita. Con il passare del tempo, Freud si accorge che ci volevano dosi sempre più forti o più frequenti per ottenere lo stesso risultato tanto che molti dei suoi pazienti finirono per assuefarsi. Così come il patologo e suo amico Ernst Fleischl, che diventerà tristemente noto alla storia come il primo caso di psicosi cocainica. Tuttavia Freud una cosa l'aveva capita molto bene: la possibilità di sfruttare questa sostanza per trarne un profitto, il suo sogno era quello di comprarsi finalmente una casa. E molti dopo di lui seguirono questa strada. Così il giovane chimico corso Angelo Mariani che a Parigi produsse quell'ottimo vino con estratti di coca che tanto Papa Leone XIII raccomandò per le messe cantate apparendo addirittura in un manifesto per farne pubblicità; mentre l'intraprendente farmacista americano John Pemberton che produsse una delle bevande ancora più bevute al mondo: la Coca cola. Ogni bottiglietta, prima del proibizionismo, conteneva l'equivalente di una piccola dose di cocaina. «Oggi la cocaina vale più del suo peso in oro. Il suo prezzo è all'origine circa il quattro per cento del prezzo di vendita al dettaglio» scrive il docente di Farmacologia di Cagliari, Gian Luigi Gessa nel suo libro Cocaina (Rubbettino, 2008), che aggiunge come «La rivista Fortune colloca l'industria della cocaina illegale al settimo posto nella lista delle cinquecento maggiori imprese economiche, tra Gulf Oil e Ford Motor Company». Nel 2003 le vendite della sostanza nelle strade americane hanno raggiunto i 35 miliardi di dollari. E non appena il mercato statunitense si è saturato, quelli in Europa si sono mostruosamente aperti. Tanto che oggi la cocaina non è più esclusiva degli strati abbienti della società, non è appannaggio di fotomodelle o imprenditori, oggi si trova raccolta in "pezzi", appallottolata nelle tasche della gente comune, nelle borsette delle signore, nei portafogli del lavoratori, negli zaini degli studenti, nella cassaforte dei politici, ovunque. Ne hanno trovato percentuali imbarazzanti perfino nelle acque dell'Arno e residui in quasi tutte le banconote che maneggiamo. Pippata, scaldata, tagliata, fumata oggi la cocaina viene usata indistintamente con o senza permesso di soggiorno, con o senza contratto a tempo indeterminato, ricco o povero, uomo o donna che sia. A fronte di una politica del guadagno folle che sta giustificando militarizzazioni e politiche proibizioniste che riempiono le galere. Potremmo dire che è tutta colpa degli inca? Gli abitanti dell'area compresa tra Colombia, Perù e Bolivia, dove si producono i tre quarti della cocaina del mondo, masticano foglie di coca da migliaia di anni. Non solo per le sue proprietà stimolanti - che cancellano la fatica e danno l'energia necessaria per affrontare le ripide salite nell'aria rarefatta di quella regione montuosa - ma anche per le sue qualità alimentari, poiché le foglie contengono vitamine e proteine. Poi arrivarono i conquistadores con il loro divieto definendola "uno strumento del diavolo", per poi scoprire che senza quel "dono degli dei" gli indigeni non riuscivano a lavorare nei campi o a estrarre l'oro. Improvvisamente la coca fu legalizzata e anche tassata e gli invasori cominciarono a tenere per sé un decimo dei raccolti. Le foglie erano distribuite ai contadini tre o quattro volte al giorno, durante le pause dal lavoro. Addirittura la chiesa cattolica cominciò a coltivarla. Poiché le foglie sopportavano male il viaggio venivano esportate in Europa solo sporadicamente, così negli Stati Uniti, come nel Vecchio Continente ben presto arrivò la sostanza lavorata e in polvere. Una storia che però si ripete ancora oggi. Nel 2006 il regista Andrea Zambelli si reca in Colombia per un progetto di alfabetizzazione comunicativa, qui realizza Mercancia , un documentario che segue tutto il processo di "fabbricazione" di questa sostanza nella regione del Magdalena-Medio, nei vari passaggi di produzione fino alla pasta. Ma soprattutto raccoglie il racconto degli stessi contadini e si sofferma sui gruppi paramilitari che gestiscono gli scambi della cocaina fra campesinos e narcotrafficanti. Dalla raccolta della pianta fino alla raffinazione ogni passo viene tassato dai gruppi paramilitari come una qualsiasi transazione economica. In venti velocissimi minuti, il regista mostra l'esistenza di una piccola comunità di coltivatori dalle tradizioni salde e dalla vita rurale. Nulla di più distante, dunque, da ciò che nel nostro immaginario può rappresentare un narcotrafficante. Nessun campesinos, infatti, è consumatore o fruitore della cocaina, né partecipe, se non in minima parte, degli incredibili guadagni legati al commercio di questa sostanza. In questi paesi, costretti spesso a lavorare nei campi di coca per poter sostentare le proprie famiglie, i contadini tramandano di padre in figlio la tradizione per la raccolta e la preparazione della pasta. L'opprimente condizione imposta dai narcotrafficati e i metodi brutali di repressione dei paramilitari impediscono la formazioni di oppositori e i pochi sindacalisti che coraggiosamente si mettono contro di loro vengono spesso messi a tacere. Ed è proprio questo il problema principale: il guadagno. Nelle nazioni di produzione un grammo di cocaina (come reso noto dalle Direzioni internazionali per la lotta alla droga) viene pagato un euro per una purezza pari al 95%. Sul mercato occidentale bene che va viene rivenduta con soltanto il 25-30% di principio attivo, con un guadagno del 1.200%. Del resto Roberto Saviano in Gomorra ci parla di un «fatturato 60 volte superiore a quello della Fiat». E questo solo in Italia. Sarà per questo che la cocaina viene chiamata "il petrolio bianco", il vero miracolo del capitalismo contemporaneo, in grado di superare qualsiasi crisi economica. Così i mercati crollano e il prezzo della cocaina in Occidente scende ma non quello del fatturato. Un vero affare.
Cristina Petrucci
27/12/09
IL FIASCO DI COPENHAGEN. L'IMPOSSIBILE PATTO TRA AMBIENTE E CAPITALISMO

Il “Disaccordo storico” Quello che è stato sancito alla conclusione della Conferenza è stato definito un “Disaccordo storico”. Insomma, un fiasco totale scandito dall’andamento surreale dei lavori, che ripercorriamo in breve. All’inizio, come inevitabile, la fanno da padrona – tanto non costa niente – la retorica ed i buoni sentimenti. Al punto che Copenhagen diventa per i creduloni, tanto più per quelli di stretta osservanza obamiana, Hopenhagen. I media, ovviamente, parlano di clima positivo e di ottimismo. Poi, al secondo giorno, salta fuori la bozza segreta rivelata dal Guardian: una risoluzione finale già elaborata prima che la Conferenza cominciasse, del tutto sfavorevole ai paesi del terzo mondo. Che compatti rispondono picche. Da lì in avanti il previsto fallimento si è trasformato ogni giorno di più in assoluta certezza. Restava da capire come si sarebbe consumata la farsa finale. Tutti sapevano che sarebbe arrivato da Washington se non proprio il “Salvatore”, almeno il paladino della green economy. L’altro “Salvatore” – stiamo parlando del megalomane che risiede all’Eliseo, che si era attribuito la missione di “Salvare la Terra” – aveva già rinunciato al suo modestissimo proposito, andandosene da Copenhagen già al secondo giorno. Alla fine, il penultimo giorno, Obama è arrivato. Ha incontrato il primo ministro cinese, Wen Jabao, con il quale si dice abbia discusso aspramente, arrivando infine alla decisione di non decidere niente. La montagna di Copenhagen ha così partorito il più classico dei topolini: un testo privo di contenuti, di impegni, di vincoli. Un niente sottoscritto da Usa e Cina, ma anche (affinché non si parlasse troppo di G2) da India, Brasile e Sudafrica. L’Europa si è adeguata, accettando amaramente di non contare ormai più nulla. Gli altri non hanno proprio sottoscritto un bel niente, inventandosi all’atto finale la formula un po’ irrituale, ma assai significativa, della “presa d’atto”. Del resto tutti, ma proprio tutti, hanno dovuto “prendere atto” del fallimento totale di una Conferenza dove si sono fatti molti sforzi per nascondere la polvere sotto il tappeto, prima ancora che cercare di ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera.
Quel nulla chiamato “Copenhagen Accord” Sfidando arditamente il senso del ridicolo, hanno voluto chiamare “Accordo di Copenhagen”, un testo “riconosciuto”, ma non approvato dai 193 Paesi presenti alla Conferenza. La cosa più importante da capire, infatti, prima ancora del contenuto del testo “riconosciuto”, è il suo carattere assolutamente non vincolante. C’è qui un’enorme differenza con il Protocollo di Kyoto del 1997, con il quale 37 Paesi industrializzati (ma non gli Stati Uniti) si impegnavano a ridurre le emissioni di sei gas serra di almeno il 5,2% rispetto al 1990 (ormai convenzionalmente assunto come “anno zero”) entro il 2012. Il protocollo fu sottoscritto da 160 Paesi, ma imponeva la riduzione delle emissioni solo a quelli maggiormente industrializzati, 37 appunto. Sia chiaro, questi impegni sono stati completamente disattesi. Giusto per fare un esempio, basti pensare che la produzione di CO2 di questi Paesi è aumentata nel solo periodo 2000-2009 di quasi il 30%, nonostante la riduzione dell’ultimo anno dovuta agli effetti della crisi economica. Tuttavia Kyoto stabiliva almeno dei precisi obiettivi, per quanto modesti, ed i contraenti si impegnavano (anche se, come abbiamo visto, solo sulla carta) a rispettarli. Nulla di tutto ciò è avvenuto a Copenhagen. L’Accordo di Copenhagen (utilizziamo questa terminologia assolutamente impropria solo per comodità) ribadisce che “l’aumento della temperatura globale dovrebbe (notare il condizionale – ndr) restare contenuto sotto i due gradi centigradi”. Questa debolissima premessa è in realtà l’unico pezzo “forte” del documento conclusivo. Tutto il resto che era stato oggetto delle trattative che hanno preceduto la Conferenza è scomparso. Scomparsa ogni indicazione quantitativa sui tagli delle emissioni, scomparsa ogni data di riferimento. Qualcuno ricorda, ad esempio, l’obiettivo della riduzione delle emissioni del 50% entro il 2050? Totalmente scomparso. Ora ogni Paese si auto-assegnerà degli obiettivi teoricamente auto-vincolanti. Ma se non ha funzionato il protocollo di Kyoto, perché mai dovrebbe funzionare una soluzione così strampalata? Ed infatti nessuno ci crede davvero. Si è molto parlato dei finanziamenti dei Paesi ricchi a quelli poveri, per favorire il cosiddetto “sviluppo sostenibile”. In realtà anche su questo non c’è niente di certo, in particolare non si dice da dove verranno i soldi, alimentando il sospetto che si intenda stornarli da altri fondi già destinati alla “cooperazione internazionale”. Perfino l’accordo sulla protezione delle foreste, che sembrava ormai acquisito, è tornato incerto e confuso nel testo finale. L’accordo si limita a dire che “Riconosciamo il ruolo cruciale del ridurre le emissioni della deforestazione”. Insomma, a Copenhagen hanno scoperto che gli alberi assorbono anidride carbonica! Forse non avranno il Nobel – non tutti si chiamano Obama! – ma certo nessuno potrà togliergli un bell’invito alla “festa degli alberi”, con tanto di scolaresche e pic-nic.
Quali sono stati gli attori della Conferenza? Visti i contenuti dell’accordo, e prima di arrivare ad alcune necessarie conclusioni, è ora utile soffermarsi sul ruolo avuto dai diversi protagonisti della Conferenza. Di Obama si è già detto, ma restano da aggiungere due considerazioni. La prima riguarda la sua ineguagliabile faccia di bronzo, che lo ha portato a parlare di “un accordo significativo, anche se insufficiente”. La seconda riguarda invece la sua arroganza. E’ arrivato, ha chiuso l’accordicchio e se ne è ripartito di corsa verso gli Stati uniti senza neppure attendere la conclusione formale dei lavori. Ha umiliato, sapendo di umiliarla, l’Europa. Non ha degnato neppure di uno sguardo le posizioni del terzo mondo e del G77. Sull’Europa non c’è nulla da aggiungere a quanto già detto. L’Unione ama fare la prima della classe in materia ambientale, ma il suo attuale peso politico è uguale a zero ed a Copenhagen si è visto. La Russia è stata un’altra grande assente, ma forse i suoi rappresentanti, ben avvertiti della certezza del fallimento e senza la necessità di dover recitare una parte nella commedia, al contrario degli europei, hanno scelto deliberatamente di disinteressarsene. La Cina ha fatto la parte che gli compete. Ha agito da potenza emergente, ma senza perdere il contatto con i Paesi della periferia, dagli africani ai latinoamericani dell’Alba (Alleanza Bolivariana per le Americhe). Wen Jabao ha certamente portato a casa il “diritto di inquinare”, ma ha giustamente respinto il tentativo occidentale di scaricare su Pechino il fallimento della Conferenza. Giustamente, non solo perché le emissioni pro-capite dei cinesi sono ancora notevolmente più basse di quelle degli americani e degli europei, ma anche perché la Cina è il paese che sta investendo di più nei progetti ambientali, ed in generale nella cosiddetta green economy. Il G77, che raggruppa ormai 131 Paesi inclusa la Cina, ha respinto fin dall’inizio dei lavori il tentativo occidentale di scaricare anche la questione climatica sui paesi più poveri del pianeta. In particolare questo raggruppamento piuttosto composito, presieduto dal sudanese Lumumba Di-Aping, bocciando da subito la risoluzione segreta predisposta dalla presidenza danese, ha fatto emergere immediatamente le contraddizioni e l’ipocrisia dello schieramento occidentale. “Il testo ruba ai paesi in via di sviluppo la loro quota giusta ed equa di spazio atmosferico. Cerca di trattare ricchi e poveri allo stesso modo”, questo il lapidario giudizio espresso da Di-Aping. Se ferma è stata la posizione durante la Conferenza, ugualmente netto il giudizio finale: “Questo accordo infliggerà massiccia devastazione all’Africa e alle piccole nazioni-isola. Hanno mostrato il livello di ambizione più basso che si possa immaginare”. Con queste parole il presidente sudanese del G77 ha chiarito che nessuna copertura è stata data all’accordo finale, benché sottoscritto da quattro stati membri (Cina, India, Brasile e Sudafrica). Un discorso a parte va fatto per i Paesi dell’Alba. I Paesi dell’alleanza bolivariana (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Vincent e Grenadine) a Copenhagen hanno marcato con forza la loro presenza. Oltre all’importante discorso di Chavez, c’è stato un forte attivismo durante tutti i lavori della Conferenza. E per sottolineare l’assoluta alternatività delle proprie posizioni, i membri dell’Alba si sono ritrovati il 17 dicembre in una sorta di contro vertice al palazzetto dello sport del Valbyhallen dove, davanti a 3.500 persone, si sono dati il cambio al microfono Chavez, Morales e gli altri esponenti bolivariani presenti. Morales, preannunciando il fallimento certo della Conferenza, l’ha spiegato con l’inconciliabilità degli interessi e dei punti di vista in campo, ma soprattutto con l’impossibilità di fronteggiare il problema climatico affrontando solo gli effetti del riscaldamento globale, ma non le sue cause. Qual è allora l’alternativa? “El socialismo”, ha ripetuto Chavez. Nessuno pensi che le posizioni dell’Alba a Copenhagen siano state dottrinarie o propagandistiche. I rappresentanti bolivariani sono entrati decisamente nel merito dei problemi, ma mai rinunciando ad evidenziare l’inconciliabilità dell’obiettivo di difendere il pianeta con la volontà delle potenze dominanti di salvare in ogni modo il capitalismo.
L’alternativa di sistema Se la conclusione della Conferenza ha dimostrato, in negativo, che il capitalismo è strutturalmente incapace di risolvere la contraddizione tra la propria natura e le esigenze ambientali di fondo; i leader bolivariani hanno avuto il merito di far emergere, in positivo, la necessità e la possibilità di un’alternativa di sistema. Il fallimento dimostra innanzitutto la difficoltà complessiva di un sistema in crisi. Una crisi che non è solo economica, ma che si manifesta anche come incapacità di rispondere alle più elementari esigenze sociali, in questo caso il semplice diritto alla vita sul pianeta. Ma questa volta, nonostante la farsa finale di un accordo che sancisce solo il disaccordo, i potenti della terra non sono riusciti a nascondere il più clamoroso dei fiaschi. Prima di concludere ci sia concesso un breve inciso. Alcuni appassionati di dietrologia avevano ipotizzato che dietro a tanta (apparente) passione per il clima ci fosse il solito complotto per far digerire al mondo una sorta di governo planetario, o quantomeno per imporre una svolta “verde” al mondo della produzione, in modo da fare della green economy uno dei possibili traini per superare la crisi. Come è del tutto evidente, il capitalismo è assolutamente indifferente al fatto che i propri profitti vengano alimentati dall’eolico piuttosto che dal carbone, ciò che conta è che i profitti ci siano. Il capitalismo, dunque, è ben felice di poter sviluppare la green economy; quello che invece non può proprio fare è mettere in discussione il meccanismo della “crescita”, specie nei Paesi dominanti. Non dubitiamo, perciò, che alcuni settori industriali favoriscano la diffusione di dati ed analisi allarmiste, come al contrario (ma per gli stessi motivi) ve ne sono altri pronti a dimostrare che i gas serra non hanno alcun effetto sull’ambiente e sul clima. Da qui a vedere sempre in atto il complotto ce ne (dovrebbe) corre(re). La verità è che vi sono, anche in questo ambito, spinte e controspinte che corrispondono ai diversi interessi in gioco. In ogni caso, se il complotto “allarmista” vi fosse realmente stato, bisognerebbe ora spiegare il suo esito totalmente disastroso. Ma chiedere un simile esercizio ad un dietrologo sarebbe come proporre un bicchiere d’acqua minerale ad un alcolista. Chi pensava ad una “conversione ecologista” del capitalismo è dunque rimasto deluso. Il dogma della “crescita”, un concetto quantitativo che ormai si è separato da quello di “sviluppo”, non può essere messo in discussione nella cornice del sistema. Tra ambiente e capitalismo non può esserci un vero patto, meno che mai un matrimonio. Giustamente uno slogan dei manifestanti di Copenhagen, ripreso nel discorso di Chavez, diceva “Non cambiate il clima, cambiate il sistema”. Anche per la strada di un ambientalismo serio e coerente torna dunque a riproporsi la necessità di un anticapitalismo che sappia rilanciarsi sulla base di una nuova prospettiva socialista. Non era scontato che da Copenhagen giungesse questo segnale. Invece è arrivato, e forse anche questo è un segno del cambiamento di fase che stiamo vivendo.
INCANTO NOTTURNO
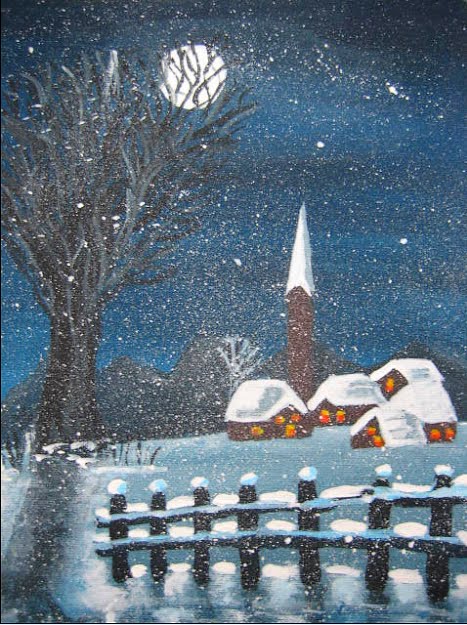
Sara
LE OCHE E I CHIERICHETTI

Bepi Zanon
TESERO 1929

Foto Anonimo
PASSATO
Foto Orco
ANCORA ROSA

Foto Archivio
VIA STAVA ANNI '30

foto Anonimo
TESERO DI BIANCO VESTITO

Foto Giuliano Sartorelli
LA BAMBOLA SABINA

Foto Euro
LA VAL DEL SALIME

Foto Euro
SEBASTIAN E IL BRENZO DI BEGNESIN

Foto di Euro Delladio
MINU

Foto di Sabina
Archivio blog
-
►
2021
(38)
- ► 11/07 - 11/14 (3)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (2)
- ► 10/17 - 10/24 (10)
- ► 10/10 - 10/17 (7)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (4)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 04/04 - 04/11 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
-
►
2020
(41)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (3)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (4)
- ► 09/13 - 09/20 (5)
- ► 09/06 - 09/13 (4)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
-
►
2019
(5)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
-
►
2018
(21)
- ► 04/22 - 04/29 (2)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (3)
- ► 01/21 - 01/28 (2)
- ► 01/14 - 01/21 (6)
- ► 01/07 - 01/14 (2)
-
►
2017
(19)
- ► 12/31 - 01/07 (1)
- ► 12/17 - 12/24 (1)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (2)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 06/25 - 07/02 (1)
- ► 06/18 - 06/25 (2)
- ► 06/11 - 06/18 (4)
- ► 06/04 - 06/11 (2)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
-
►
2016
(49)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (3)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (3)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/12 - 06/19 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (2)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (4)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
-
►
2015
(42)
- ► 12/27 - 01/03 (3)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (2)
- ► 06/14 - 06/21 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (4)
- ► 05/24 - 05/31 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (4)
- ► 05/10 - 05/17 (4)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
-
►
2014
(33)
- ► 10/05 - 10/12 (3)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/21 - 09/28 (3)
- ► 09/14 - 09/21 (3)
- ► 09/07 - 09/14 (3)
- ► 08/31 - 09/07 (4)
- ► 08/24 - 08/31 (3)
- ► 08/17 - 08/24 (7)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 07/27 - 08/03 (3)
- ► 07/13 - 07/20 (1)
-
►
2013
(35)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (5)
- ► 03/10 - 03/17 (2)
- ► 03/03 - 03/10 (4)
- ► 02/24 - 03/03 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (4)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (3)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
►
2012
(22)
- ► 12/30 - 01/06 (5)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (3)
- ► 01/15 - 01/22 (4)
- ► 01/08 - 01/15 (3)
- ► 01/01 - 01/08 (3)
-
►
2011
(39)
- ► 12/25 - 01/01 (3)
- ► 12/18 - 12/25 (4)
- ► 12/11 - 12/18 (6)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (7)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 09/11 - 09/18 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2010
(127)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (3)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ► 10/10 - 10/17 (4)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (4)
- ► 09/19 - 09/26 (4)
- ► 09/12 - 09/19 (9)
- ► 09/05 - 09/12 (6)
- ► 08/29 - 09/05 (5)
- ► 08/22 - 08/29 (8)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (3)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 03/28 - 04/04 (5)
- ► 03/21 - 03/28 (7)
- ► 03/14 - 03/21 (6)
- ► 03/07 - 03/14 (4)
- ► 02/28 - 03/07 (5)
- ► 02/21 - 02/28 (4)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (5)
- ► 01/31 - 02/07 (5)
- ► 01/24 - 01/31 (6)
- ► 01/17 - 01/24 (6)
- ► 01/10 - 01/17 (5)
- ► 01/03 - 01/10 (3)
-
▼
2009
(123)
- ▼ 12/27 - 01/03 (6)
- ► 12/20 - 12/27 (6)
- ► 12/13 - 12/20 (5)
- ► 12/06 - 12/13 (5)
- ► 11/29 - 12/06 (5)
- ► 11/22 - 11/29 (5)
- ► 11/15 - 11/22 (7)
- ► 11/08 - 11/15 (7)
- ► 11/01 - 11/08 (6)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (5)
- ► 10/11 - 10/18 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 04/12 - 04/19 (4)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (4)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (3)
- ► 03/01 - 03/08 (5)
- ► 02/22 - 03/01 (4)
- ► 02/15 - 02/22 (4)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/25 - 02/01 (5)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
- ► 01/04 - 01/11 (6)
-
►
2008
(231)
- ► 12/28 - 01/04 (5)
- ► 12/21 - 12/28 (3)
- ► 12/14 - 12/21 (4)
- ► 12/07 - 12/14 (4)
- ► 11/30 - 12/07 (4)
- ► 11/23 - 11/30 (4)
- ► 11/16 - 11/23 (5)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (5)
- ► 10/26 - 11/02 (5)
- ► 10/19 - 10/26 (5)
- ► 10/12 - 10/19 (4)
- ► 10/05 - 10/12 (6)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (6)
- ► 09/14 - 09/21 (5)
- ► 09/07 - 09/14 (5)
- ► 08/31 - 09/07 (4)
- ► 08/24 - 08/31 (5)
- ► 08/17 - 08/24 (4)
- ► 08/10 - 08/17 (3)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (4)
- ► 07/20 - 07/27 (3)
- ► 07/13 - 07/20 (4)
- ► 07/06 - 07/13 (5)
- ► 06/29 - 07/06 (4)
- ► 06/22 - 06/29 (6)
- ► 06/15 - 06/22 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (6)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
- ► 05/25 - 06/01 (4)
- ► 05/18 - 05/25 (8)
- ► 05/11 - 05/18 (4)
- ► 05/04 - 05/11 (7)
- ► 04/27 - 05/04 (5)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (5)
- ► 04/06 - 04/13 (5)
- ► 03/30 - 04/06 (5)
- ► 03/23 - 03/30 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (4)
- ► 03/09 - 03/16 (3)
- ► 03/02 - 03/09 (2)
- ► 02/24 - 03/02 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (5)
- ► 02/10 - 02/17 (4)
- ► 02/03 - 02/10 (4)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (4)
- ► 01/13 - 01/20 (6)
- ► 01/06 - 01/13 (5)
-
►
2007
(136)
- ► 12/30 - 01/06 (5)
- ► 12/23 - 12/30 (3)
- ► 12/16 - 12/23 (4)
- ► 12/09 - 12/16 (4)
- ► 12/02 - 12/09 (6)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (5)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (2)
- ► 10/28 - 11/04 (3)
- ► 10/21 - 10/28 (5)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (3)
- ► 09/30 - 10/07 (3)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/16 - 09/23 (5)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (4)
- ► 07/22 - 07/29 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (6)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (3)
- ► 06/24 - 07/01 (4)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 06/03 - 06/10 (4)
- ► 05/27 - 06/03 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (5)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 04/22 - 04/29 (2)
- ► 04/15 - 04/22 (6)
- ► 04/08 - 04/15 (11)