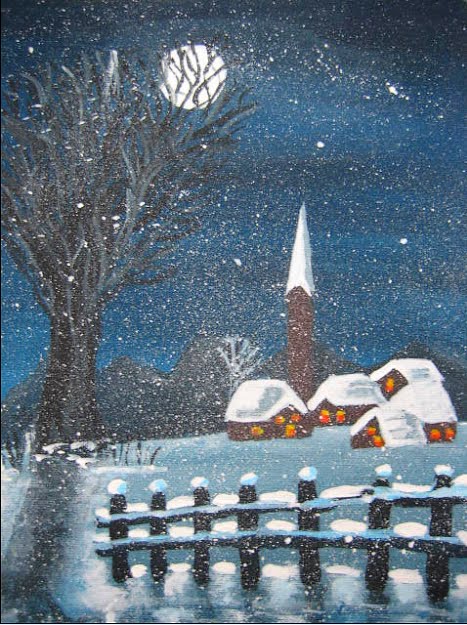Salgo verso la diga all’alba, sul filo dei tornanti. Echi d’acqua nel vuoto. Cielo terso e sottozero. Fino all’ultimo curvone, dopo la galleria, quando compare dal silenzio della valle. Eccola, la diga. È un uragano imprigionato dal cemento. Il riflesso congelato di un abisso. Ci sono piccoli vortici di vento. Pietre che cascano con cento rimbalzi. Corvi che salgono a spirale. E il vuoto del silenzio che ancora fa paura.
Prima di tutti quei morti, 1910 vittime in 4 minuti, scorticati dal vento, annegati dall’acqua, soffocati dal fango, era bella la valle del Vajont. Con i boschi di larice rosso, gli alberi da frutta sui poggi, i vigneti, i mulini, le fonti. E accanto alle fonti le chiesette medioevali e l’osteria. C’erano paesi minuscoli, fatti di pietra, ponti sospesi, e i pratoni dove scivolava il verde della primavera e ora fiorisce il ghiaccio dell’inverno.
La valle, come allora, scende a triangolo dalle rocce contorte del Cadore, tra il Monte Toc e gli strapiombi del Col Nudo. Scendendo si allarga sino alla spianata, dove respira la nuova Longarone e accanto corre il Piave che ha ghiaia bianca, musica d’acqua che mormora e luce a specchio quando il sole brilla in cima alle spalle delle Dolomiti.
Vajont è il nome del torrente. In lingua ladina significa “vien giù” perché corre verticale e dove passa scava, e dove scava vien giù la roccia. Nell’ultimo tratto, bagna l’argilla del Monte Toc che in dialetto friulano custodisce la memoria di ancestrali spaventi e frane e massi rotolanti fissati in quel “toc” che è come dire marcio, friabile.
Tutto stava già nella lingua – e nel buon senso – a ben vedere: il monte d’argilla con i piedi immersi nell’acqua che scava. Il monte d’argilla che marcisce, scivola, frana dentro al nuovo lago. Il lago che esplode, scavalca la diga, spazza la valle, precipita, uccide.
Ma gli ingegneri se ne infischiano delle lingue. E il progresso se ne frega del buon senso. L’ingegner Carlo Semenza, nell’anno 1940, disegna la diga a doppio arco, resistente, perfetta. Il geologo Giorgio Dal Piaz dice che l’imbuto della valle reggerà il peso del nuovo lago. Il conte Volpi, proprietario della Sade, monopolista dell’elettricità, vuole a tutti i costi la diga.
Per Semenza, l’ingegnere, sarà il capolavoro della vita. Per Dal Piaz, che ha la barba bianca da geologo, sarà la buona pensione, dopo l’addio alla cattedra. Per la Sade è investimento, sviluppo, fatturato. Per l’Italia, il progresso.
I luminari delle università di Padova, Torino, Venezia, che viaggiano a spese della Sade, periziano in favore della Sade: “Si può fare, si faccia”. I grandi giornali esultano. Chi mai dà retta ai contadini e ai montanari che fiutano le frane? Chi mai ascolta le vecchie storie sul torrente Vajont, vien giù, e sul Monte Toc, marcio, friabile?
Perciò il governo vara. Finanzia al 45 per cento. Mette in moto i numeri. E i numeri, nell’anno 1956, quando iniziano i lavori della diga, dicono che metà della valle sparirà insieme con il suo passato improduttivo, antimoderno, di paesi analfabeti, bestiame, alpeggi solitari, emigrazione e fame. Tutto da cancellare sotto la superficie smagliante del progresso e del nuovo lago artificiale, 168 milioni di metri cubi d’acqua. Tutto da mettere in moto, una buona volta, insieme con le nuove turbine d’alto voltaggio per l’acciaio e la chimica di Marghera che ogni notte incendia il cielo sopra la Laguna. L’Italia del Boom divora energia. Il suo fabbisogno cresce come una febbre e la diga del Vajont è una medicina da 150 milioni di chilowattora. Nutrirà i capannoni del Friuli e i laminatoi del Veneto. Accenderà nuove fabbriche e nuove opportunità di lavoro. Correre, correre. Questo è il Miracolo economico che arriva con gli ingegneri, i geologi, i cantieri e il nuovo orologio del tempo: il progresso. Non c’è modo di opporsi: un milione di metri quadri di pascoli espropriati a 3 lire e 94 centesimi al metro quadro. La valle divisa a metà. Le strade di sterrato che salgono a tornanti, si riempiono di camion in marcia verso il cantiere. Verso la diga che cresce. Energia elettrica per tutti, soldi per tutti, numeri per tutti.
La diga e il Miracolo crescono insieme, dal 1957 al 1962. Come il grattacielo Pirelli a Milano. Come i capannoni di Mirafiori a Torino. Come le prime code autostradali verso il mare e i cinegiornali spalancati sui denti bianchi delle massaie e la geometria americana dei frigoriferi.
Nessun altro simbolo però è così carico di inganni quanto la diga del Vajont. Dietro alle sue spalle di cemento e acciaio, dentro a quello sterminato bacino di acqua che inghiottirà la valle, verranno a galla insieme con i morti tutti i difetti e le menzogne e le fragilità dello sviluppo italiano. In nome del quale il potere economico della Sade piega quello politico. Le commissioni di controllo non controllano. I periti non fanno i collaudi. I grandi giornali non informano.
Il Vajont, che oscurerà i fasti del Miracolo, è la più grande strage del Dopoguerra italiano. La prima a trascinarsi una coda infinita di sentenze, disinformazione, risarcimenti, Commissioni parlamentari d’inchiesta, perizie, controperizie, rallentamenti, compreso il trasferimento preventivo del processo in altra sede, per “ragioni di ordine pubblico”, dal tribunale naturale di Belluno a quello remoto dell’Aquila, 850 chilometri più a sud, come avverrà una manciata di anni dopo per piazza Fontana.
Ma il Vajont e la sua tragedia sono anche l’inizio – nell’Italia dei nuovissimi televisori – di un’opinione pubblica che albeggia sul nero della cronaca. È la piccola luce delle telecamere che si accende sul fango e sulle facce dei superstiti, le loro storie di lacrime, rabbia, ingiustizia. Per la prima volta il bianco e nero della verità archivia i colori letterari dei grandi inviati della carta stampata, che raccontavano, nei viaggi e nei reportage, mondi invisibili ai lettori. Stavolta no, il piccolo mondo del Vajont si vede. Si vede la diga intatta e la valle distrutta. Si vedono le lacrime dei superstiti e si ascolta il furore dei loro racconti. Stavolta l’inchiostro di Dino Buzzati, che sul Corriere della Sera scrive “un sasso è caduto in un bicchiere”, “la tovaglia si è bagnata”, “fatalità della Natura”, “nessuno poteva prevedere”, diventa esercizio di stile incongruo, elzeviro per miopi.
Sono i giovani cronisti a risaltare in quella nuova luce. Come Tina Merlin e Mario Passi dell’Unità, come gli inviati del nuovo settimanale L’Espresso che scrivono la storia di quello che si vede: catastrofe “prevedibile e prevista” e poi “negligenza, imperizia, colpa”. Che rendono stonata la voce liturgica del presidente della Repubblica Antonio Segni e dei suoi ministri che in televisione allargano le braccia e parlano di “sventura che bussa alla porta”.
Nei loro racconti questi giovani giornalisti illuminano con la cronaca degli antefatti il dramma delle conseguenze. Spiegano gli inganni del disastro sul quale, per la prima volta, si accendono le fotoelettriche della televisione, imprimendo all’Italia e agli italiani la memoria perpetua di quell’unica distesa di fango e di bugie che ha appena cancellato Longarone. (…)
Pino Corrias (LUOGHI COMUNI – Rizzoli 2006)